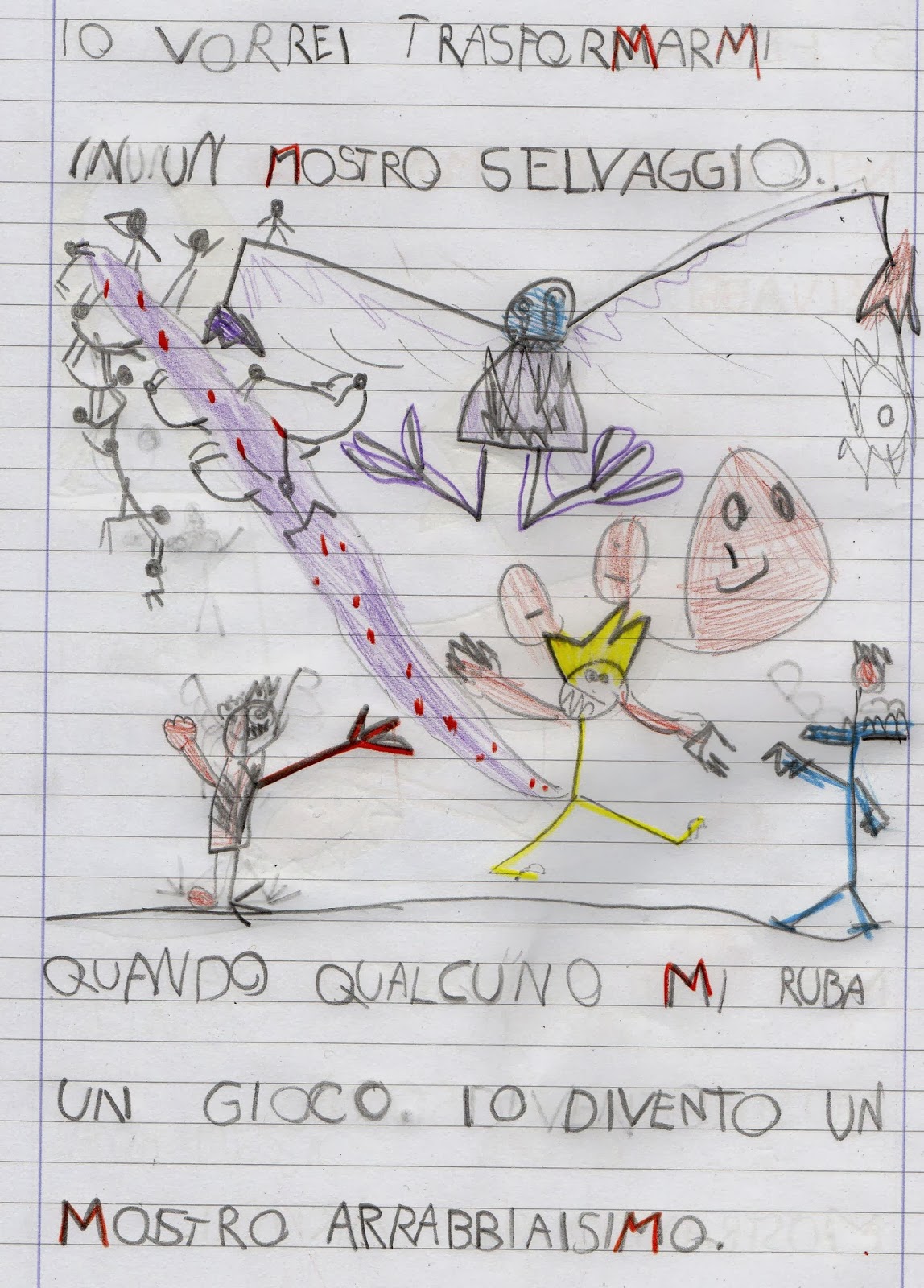Sappiamo che “ […] La modalità di
pensiero del bambino nei suoi primi sette anni di vita è in buona misura
contrapposta alla modalità logica degli adulti, ed è caratterizzata dall’incapacità di
distinguere i propri pensieri, desideri, emozioni da quelli degli altri esseri
umani; inoltre, questo tipo di pensiero è permeato di animismo, attribuisce cioè sentimenti,
volontà, possibilità di azione a tutti gli altri esseri del mondo, anche a
quelli inanimati.” (da Uppa).
Primi
sette anni di vita: i miei bambini e le mie bambine si trovano quindi in quella
delicata fase di passaggio tra la fine del pensiero magico e la consapevolezza
della naturale, e realistica corrispondenza causa-effetto nel manifestarsi degli
eventi della propria vita.
Eppure,
chi può dire quando davvero si esaurisca il pensiero magico? Cosa sono, se non
manifestazioni della sua persistenza, le superstizioni, i riti propiziatori o
scaramantici, i gesti ripetuti che ritornano “ogni volta che il pensiero logico
non riesce a essere rassicurante di fronte a eventi
paurosi o di fronte al desiderio di veder realizzato un desiderio”?
Così,
la lettura di La mia magia, su testo di Gaia Guasti e illustrazioni di Simona
Mulazzani, Camelozampa, stimola nei bambini riflessioni su se stessi e sugli
altri (La tua magia è venire a scuola, mi
dice uno. E l’altra, di rimando: La tua
magia è raccontare le storie ai bambini).
E se l’esempio più lampante di questo
momento di passaggio dal pensiero magico ad un pensiero logico mi pare quello
che permette ad A. di affermare: “La mia
magia è quando sono vicina al passaggio a livello, io dico una parola e lui si
apre (a volte succede, a volte no).”, altri si trasformano in supereroi, leggono
libri di incantesimi o fanno trucchi con
carte e foulard. Per qualcuno, magia è cantare; per qualcun altro, non far arrabbiare
mamma e papà.


Ma
quale sarà la nostra magia, quella che possiamo realizzare insieme, come
classe?
Sono
curiosa di chiederlo ai bambini.
-------------------
P.s. aggiunto alle 14.00
La nostra magia è:
-------------------
P.s. aggiunto alle 14.00
La nostra magia è:
leggere
i libri insieme
giocare
nel giardino della scuola
aiutarci
a vicenda
pitturare
insieme
fare
lavori di squadra, fare dei lavori insieme
usare
la lim insieme, con la maestra
il
silenzio che si crea in alcuni momenti speciali
quando
tutti noi insieme facciamo la pace
quando
la maestra ci legge le storie
la
scuola
abbracciarsi,
quando facciamo il cerchio degli abbracci
dire
le parole belle del sabato e della domenica
volerci
bene
fare
il giro degli abbracci
essere
amici
leggere
i libri
giocare
tutti insieme
essere
amici tutti
imparare
nuove cose
andare
in palestra
fare
i bravi
scrivere
condividere
le cose con i compagni
ascoltare
la maestra
rispettare
le maestre e i compagni e volergli bene
salutare
tutti i nostri amici
Come
incomincia:
Tutto quello che
esiste sulla terra, e anche la terra, la luna e ogni pianeta fino ai confini
del mondo, è la mia magia.
La mattina il
sole sorge per scaldarmi.
La mucca fa il
mio latte. Il fornaio cuoce il pane per me.
Le mie nuvole
corrono in cielo.
Il gatto mi fa le
fusa.
Gaia
Guasti – Simona Mulazzani, La mia Magia, Camelozampa